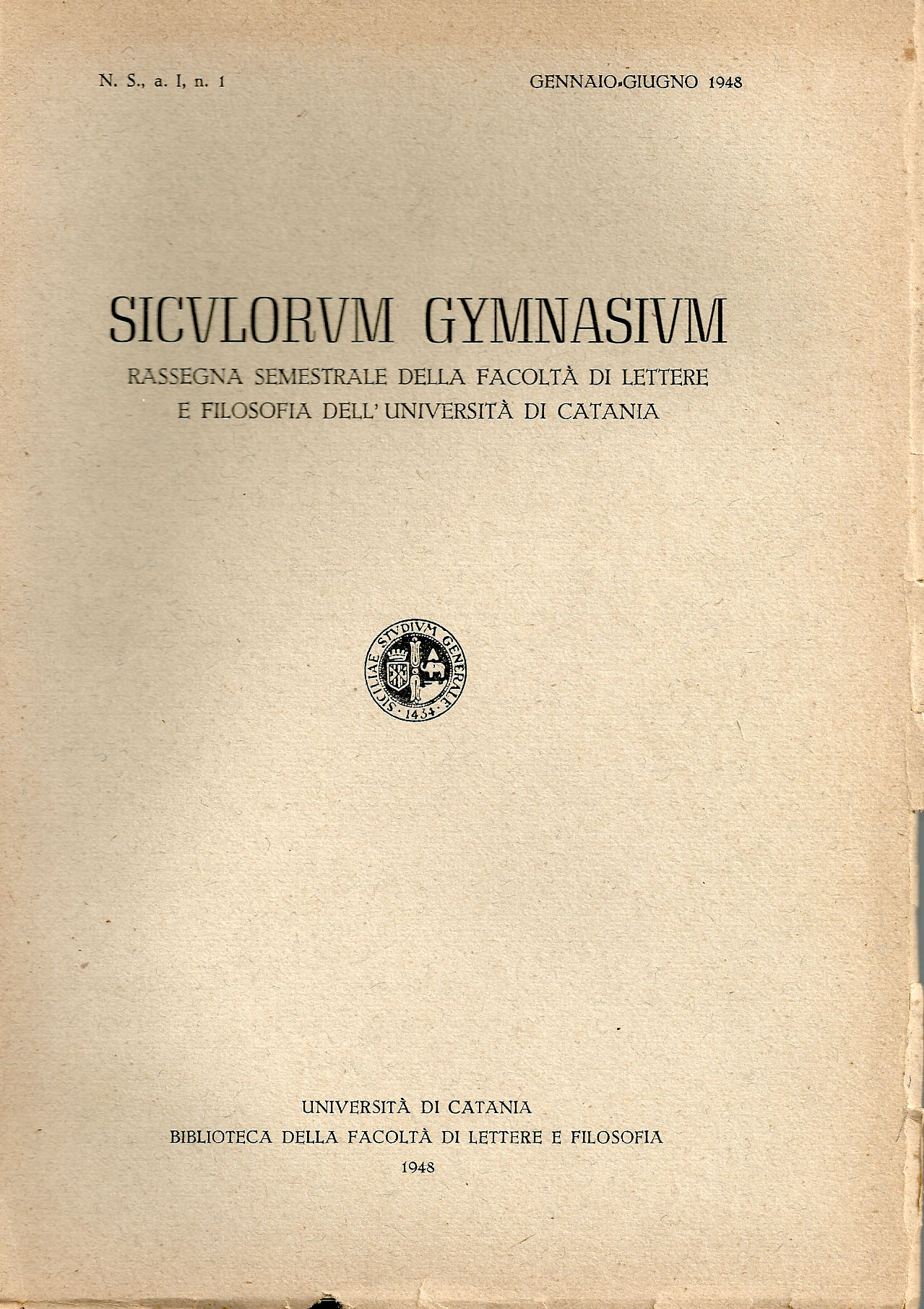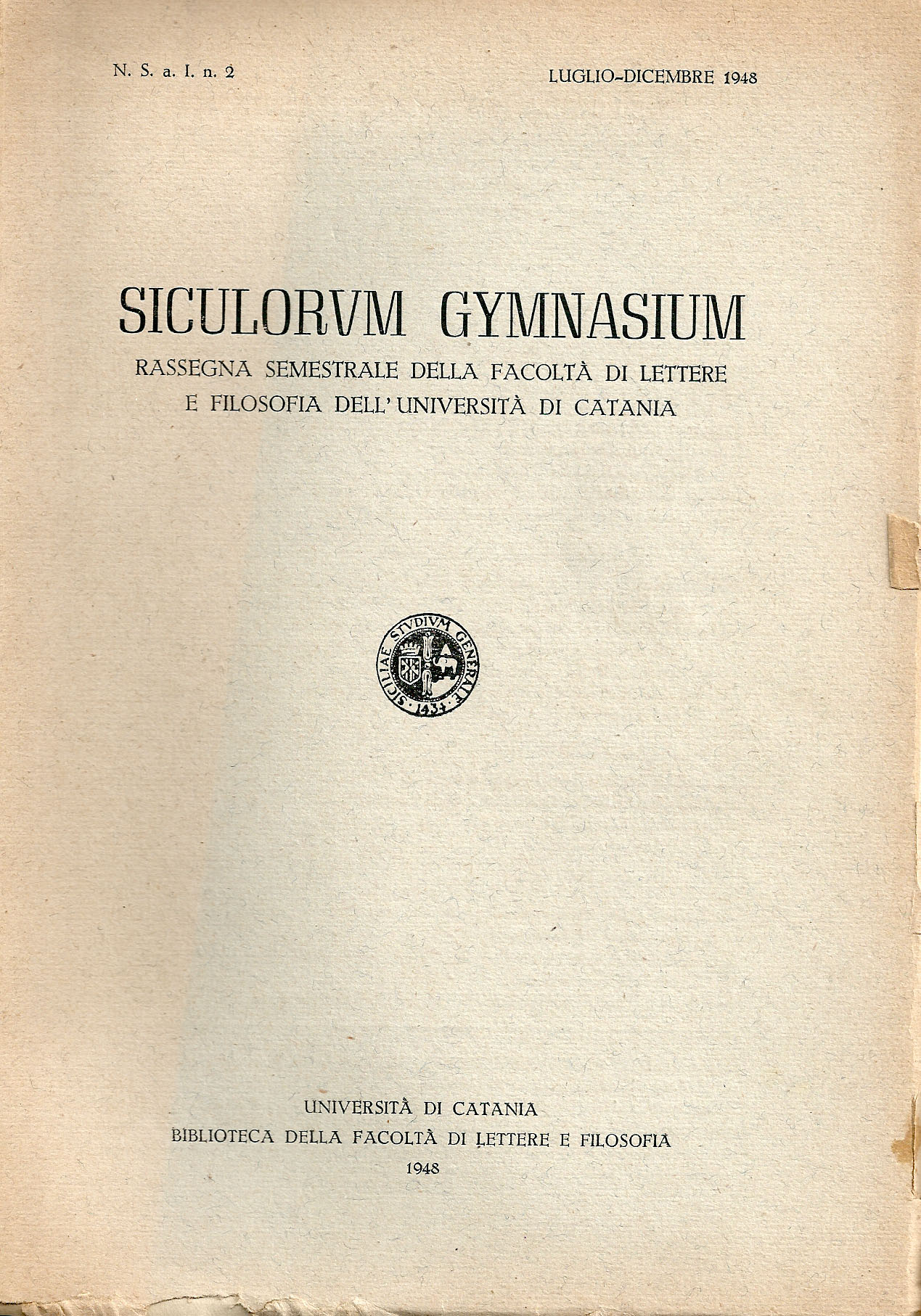Guardando al «Siculorum» del 1948
Riflettere sulla prima annata del «Siculorum», datata 1948, vuol dire anzitutto per noi riconnetterci simbolicamente al principio, alle pagine da cui tutto ha avuto inizio, ma significa anche specchiarci in una temperie sociale, culturale e politica molto diversa. Si tratta, in altre parole, di un’occasione per comprendere noi stessi a partire da un passato recente ma lontanissimo, vista la velocità estrema dei cambiamenti succedutisi lungo questi settant’anni. Cominciamo insomma la nostra sezione di Riletture da un tentativo di conversazione sul nostro ieri e sul nostro oggi, in vista di un domani incerto, difficilmente prevedibile ma (altrettanto) ineludibile. In questa riflessione, i primi due numeri del «Siculorum Gymnasium» ci fanno da falsariga e da apripista, in quanto affrontano alcune tematiche decisive anche in ordine al senso della cultura umanistica, al suo ruolo e ai suoi spazi nella società, ai suoi orizzonti di ricerca e ai suoi atteggiamenti etici, ai suoi saperi e alle sue forme.
Abbiamo inviato i due numeri in digitale a quattro studiosi – due interni al nostro Dipartimento e due di altre Università –, rappresentanti di diverse aree della ricerca umanistica: Francesco Benigno, storico dell’Università di Teramo, Edoardo Massimilla, storico della filosofia dell’Università Federico II di Napoli, Valter Pinto, storico dell’arte, e Antonio Pioletti, filologo, entrambi del nostro Dipartimento di Scienze Umanistiche. Abbiamo chiesto loro di rispondere ad alcune questioni poste dalla redazione.
«Siculorum Gymnasium» fasc. 1, gennaio – giugno 1948
«Siculorum Gymnasium» fasc. 2, luglio – dicembre 1948
Partiamo da un elemento apparentemente secondario ma di grande portata simbolica. Nel secondo numero di «Siculorum Gymnasium», quello del luglio-dicembre 1948, sono contenuti in poche pagine finali, numerate a parte (I-XIX) e di colore azzurro, i programmi, gli orari, le norme per le iscrizioni, le tasse e le avvertenze relative alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Catania. Era il risvolto di un’università ‘semplice’, ancora elitaria, che richiedeva un livello di tassazione inaccessibile ai lavoratori manuali (sebbene l’esonero parziale o totale dalle tasse fosse garantito ai meritevoli provenienti da famiglie disagiate). Ma era anche il segno di un’università i cui compiti sociali e culturali erano molto precisi, dove le materie di studio erano poche e identificabili, i programmi semplici ed essenziali, il magistero dei docenti assolutamente centrale (era, quella di allora a Catania, ricordiamolo, la Facoltà di Lettere di Cataudella, di Macchia, di Mazzarino). Poi, in pochi decenni, è cambiato tutto: abbiamo attraversato il Sessantotto, la nascita di un’università di massa, la crisi degli ultimi anni, la restrizione progressiva degli spazi e degli accessi, l’oscillazione attuale su statuto e missione delle istituzioni accademiche, la nuova frattura Nord-Sud. Ecco, vorremmo chiedervi la vostra impressione a tal riguardo. Sfogliando quei numeri del «Siculorum» ritenete che quel modello abbia, nella crisi attuale, ancora qualcosa da dirci? E soprattutto: la sua essenzialità formale, la sua implicita concezione squisitamente umanistica degli studi e della formazione universitaria possono in qualche modo essere ancora ‘mediate’, ovvero vi appaiono del tutto superate?
Benigno – Il fascicolo ci racconta anzitutto di un’altra università, che è parte di un mondo in cui l’accesso agli studi superiori era un privilegio e una garanzia di mobilità sociale: un’università per pochi, incaricata di formare la classe dirigente del paese. Gli studi umanistici e classici avevano, in tale contesto, una funzione specifica, ossia quella di riprodurre una élite che si potesse identificare in alcuni tratti culturali, attraverso un processo che Pierre Bourdieu per primo ci ha insegnato a pensare come ruotante attorno alla «distinzione». Di quell’università spesso si ricordano, in positivo e talora con nostalgia, le lezioni magistrali di alcuni grandi studiosi, la libertà da impacci burocratici, il diretto legame tra ricerca e insegnamento, il gusto un po’ snob di molto leggere e poco scrivere. Tutto vero. Ma gli storici sono abituati a diffidare della memoria dei propri attori e ancor più se questa memoria è segnata dal rimpianto per una giovinezza che non c’è più e per dei riconoscimenti perduti, per una posizione sociale di privilegio tramontata.
Bisogna avere l’onestà intellettuale di ricordare come quell’università si è dimostrata colpevolmente in affanno (e non solo per demerito di una politica distratta) nel seguire le evoluzioni della società italiana e a lungo, troppo a lungo, incapace a trasformarsi – mediante opportune riforme – in un’obbligata università di massa. Si tende a dimenticare l’ostinazione di corsi monografici astrusi e slegati da qualunque riferimento contestuale, l’abitudine a non rispettare calendari didattici e altri adempimenti della vita accademica, le frequenti sostituzioni dei docenti con personale avventizio, la tendenza a considerare lo studente uno spettatore occasionale e marginale nelle scelte di politica universitaria; e infine, sopraggiunte negli anni Sessanta le grandi folle, la trasformazione dell’università in un esamificio. Capita ancora oggi che molti colleghi, al solo sentir parlare di internazionalizzazione, valutazione della ricerca, crediti, prove intermedie e quant’altro previsto dal processo di Bologna, siano presi dallo sconforto e confessino di non sentirsi a loro agio, di non riconoscersi più nell’università di oggi. Si tratta della migliore conferma dei cambiamenti verificatisi e, a ben vedere, dell’autodenuncia della difficoltà di questi colleghi a cambiare e ad abbandonare abitudini comode o comunque familiari. Tutto questo viene spesso ammantato da una retorica di laudatores temporis acti, in cui, paragonando il presente all’immagine idealizzata e colpevolmente omissiva del passato, se ne traggono funeste visioni di declino e di imbarbarimento aziendalista.
A questi colleghi andrebbe rammentata l’immagine che di quella università ci hanno offerto i giornali in una delle poche occasioni in cui i cronisti hanno davvero diffusamente ‘ficcato il naso’ nella vita universitaria, vale a dire in occasione del disgraziato omicidio di Marta Russo. Ma davvero è possibile rimpiangere un’università come quella offerta dalle descrizioni particolareggiate, in dettaglio, che se ne fecero? Un’università che resisteva alla dipartimentalizzazione e si rinserrava in istituti che conservavano gelosamente i libri della disciplina, secondo l’idea diffusa che per i professori fosse meglio averli in un armadietto ben piazzato dietro la propria scrivania? Un’università dominata dalla figura mitizzata del Professore, che veniva poco, insegnava meno e partecipava alla vita collegiale meno ancora? Un’università popolata da figure di apprendisti come Scattone, che – senza essere pagati e senza averne titolo – svolgevano tutte le funzioni ufficiali del docente (lezione, ricevimento etc.) e che come tali erano non impropriamente chiamati professori dagli studenti? Guardare con realismo al passato non significa idealizzare il presente, naturalmente. Ma riconoscere con nettezza quello che ci resta ancora da fare: vale a dire costruire un’università meno chiusa e autoreferenziale e più internazionalizzata.
Massimilla – Ritengo che la crisi attuale dell’università sia strettamente connessa, specie nel nostro paese, alla mancanza di una ’idea di fondo’ per un verso paragonabile a quella che stava dietro alle istituzioni accademiche del «passato recente ma lontanissimo» di cui stiamo parlando, e per un altro verso capace di fornire una risposta convincente e creativa alle esigenze sorte dalle radicali trasformazioni economico-sociali, politiche e culturali degli ultimi decenni. Prive di questa stella polare, le molte, le troppe riforme dell’università che si sono succedute hanno dunque navigato a vista, imitando in modo esteriore e ondivago modelli altrui. Certo, nella vita universitaria italiana più recente non mancano esperienze di nuovo genere che meritano di essere salvaguardate e proseguite. Ma anche questi singoli elementi positivi non ruotano attorno ad un centro di gravità ben definito e restano dunque sconnessi l’uno dall’altro.
Si tratterebbe perciò – come ha a più riprese messo in evidenza Fulvio Tessitore – di sviluppare una seria riflessione (il che significa: una riflessione filosofica) sulle nuove frontiere della ricerca scientifica, le quali sono ovunque tracciate da inediti processi d’interazione tra i saperi particolari che nulla hanno a che vedere con un ritorno al dilettantismo, rappresentando piuttosto l’esito più recente e, per certi versi, inatteso di un percorso lunghissimo e molto complicato che prende le mosse dalla rivoluzione gnoseologica moderna. Alla luce di ciò si dovrebbe, al contempo, avviare una coraggiosa e non formalistica ristrutturazione della didattica universitaria, la quale (oggi come ieri) è degna di questo nome solo se è legata filo doppio con gli effettivi sviluppi della ricerca scientifica. Su queste basi sarebbe davvero possibile ciò che giustamente e da più parti s’invoca, vale a dire un rilancio ‘in grande stile’ dell’università pubblica in Italia (a patto, beninteso, di metter finalmente in campo un’adeguata politica di investimenti). Entro un simile orizzonte va anche tematizzata e affrontata, a mio parere, la questione (tutt’altro che periferica) degli ‘scenari futuri’ della formazione umanistica, sottraendola a quella ‘immagine da operetta’ cui, in maniera ricorrente, cercano di riportarla ripetitori inconsapevoli o interessati della fable convenue delle ‘due culture’, l’un contro l’altra armata.
Pinto – «Un’università ‘semplice’ […] dove le materie di studio erano poche e identificabili, i programmi semplici ed essenziali»; un esempio: «Storia dell’arte, prof. Stefano Bottari – lezioni, giorni pari ore 11-12, esercitazioni (dott. Ugo Ferroni), giovedì e sabato ore 17-18. Corso monografico: Problemi di scultura pisana. Corso generale: Manuali consigliati: Solmi, D’Ancona, Bottari. Parte introduttiva: Libri consigliati: Marangoni (Saper vedere, Come si guarda un quadro). Esercitazioni: L’impressionismo francese». Tre ore di lezione alla settimana, due di esercitazione (una anche il sabato pomeriggio!), per un totale, verosimilmente, di sessanta più quaranta ore. Un programma che evidentemente spaziava dal medioevo, la scultura pisana, all’Ottocento almeno, l’impressionismo. Disciplina obbligatoria al primo anno dell’indirizzo moderno, da scegliere al secondo o al terzo anno dell’indirizzo classico. Sarebbe interessante conoscere le statistiche: quanti studenti si iscrivevano al primo anno, quanti erano in regola con gli esami, quanti si perdevano nel corso degli anni e così via.
Sarebbe interessante provare a capire come un corso del genere, che oggi apparirebbe esageratamente lungo e insuperabile, fosse stato concepito da un docente, Bottari, che da autore di manuale si preoccupava di «ridurre all’‘essenziale’ in modo che “si incida nell’animo dei giovani”», fornendo «lineamenti sommari ma precisi», un percorso «fondato sugli elementi linguistici, e [...] integrato, come si fa per tutte le altre discipline, da letture di opere o di gruppi di opere, distribuite nei vari anni» e non da «una indifferenziata sfilata di nomi e di opere, così come si trova ammannita in tanti sciagurati “riassunti”, o nei così detti manuali che circolano nelle scuole» (le parole di Bottari sono riportate da S. Nicolini, Stefano Bottari e l’insegnamento della storia dell’arte nella scuola italiana …, «Predella: journal of visual arts», 33, 2013, pp. 279-296, citazione a p. 281).
Un interesse evidentemente non dovuto a semplice curiosità, ma piuttosto utile a meglio comprendere la ragione di ricorrenti e spesso, credo, anche manierate sollecitazioni che, soprattutto dagli ambiti gestionali, giungono a noi umanisti a semplificare, standardizzare, rendere oggettivi e programmabili i nostri corsi e percorsi di studio. E tuttavia, dovrebbe apparire evidente che analizzare criticamente fenomeni storici e culturali, interpretare testi verbali e figurativi – gli obiettivi ovvi, e minimi, della formazione universitaria – non può essere il risultato di più o meno sofisticate procedure ma è raggiungibile solo attraverso un faticoso, talvolta gratificante, corpo a corpo con gli oggetti dei nostri studi. Ci si dovrà tornare in seguito, ma a me sembra che quella concezione umanistica che traspare dai primi fascicoli del «Siculorum Gymnasium» non solo non sia superata ma anzi dovrebbe, seppure aggiornata, essere ampiamente recuperata e ripresa a modello: allora il giurista, il medico, lo scienziato non solo avevano una solida base umanistica nella loro formazione ma la coltivavano, oggi il cinquantotto per cento della nostra classe dirigente non legge un libro in un anno, stando ai dati presentati alla Buchmesse di Francoforte di questi giorni, e solamente la mancanza di statistiche non ci fa inorridire al pensiero dei musei frequentati solo per eventi mondani.
Pioletti – Non si può celare, per chi si è formato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Catania e successivamente vi ha anche svolto attività di docenza, una certa emozione nel riprendere visione dei primissimi fascicoli del «Siculorum Gymnasium», storica rivista della Facoltà. Uno sguardo al passato che rievoca un cammino seguìto e induce a riflessioni sull’oggi che non avrebbe senso rivolgere a giudizi di merito circa un presunto valore in sé da privilegiare nel prendere in esame modelli diversi di università. Ancora una volta è necessario storicizzare e registrare i momenti di rottura e, se si profilano, le linee di continuità. Se si volge lo sguardo al 1948, è inevitabile pensare agli anni del secondo dopoguerra, alla ripresa democratica, all’avvio di una rinascita economica e sociale che troverà una sua stazione negli anni Sessanta. In seguito, il quadro di riferimento muterà ancora, in modo decisivo a partire dalla metà degli anni Settanta, lungo il crinale degli Ottanta, fino alla crisi del 2007, entro la quale ancor oggi, ma con segni di ulteriori mutamenti, ci troviamo. Ed è inevitabile altresì pensare al modello humboldtiano di università e a nobili tentativi di ricostruire, dopo le macerie della guerra, una (la) tradizione della cultura occidentale, minacciata – ebbe da parte di taluni a ritenersi – dall’imbarbarimento culturale che l’irruzione delle ‘masse’ nello scenario del vivere civile (direi della storia) aveva e avrebbe comportato.
Se di quella fase è inevitabile cogliere una marcata impronta classicistica, di lunga durata anche negli anni successivi, un’idea di tradizione occidentale ed europea totalizzante in funzione anti-slava e anti-orientale, un approccio crociano nella lettura dei testi letterari, uno storicismo lineare e teleologico, è altrettanto doveroso registrare tendenze diverse che troveranno proficui sviluppi successivi. È certo da registrare l’esistenza di un’università come universitas scientiarum, nella quale c’era un rapporto complementare tra studium e ricerca, fondato sull’idea di una scienza aperta nell’ambito di una dimensione pubblica con intervento statale. Un’università funzionale alla formazione delle classi dirigenti, d’élite e classista. La sua funzione era certamente chiara, il paradigma culturale ben definito, a marcata impronta umanistica, senza che questo ebbe a impedire risultati di rilievo nelle ricerche condotte nell’ambito delle scienze fisico-naturali. Questo modello ha ancora qualcosa da dirci?
È un modello che andava superato ed è stato superato, non solo per il mutamento intervenuto progressivamente nel contesto economico-sociale e nello sviluppo stesso degli esiti della ricerca scientifica, ma anche per le sue opzioni culturali sopra sinteticamente indicate. Il Sessantotto ha rappresentato una spia della sua crisi e ha posto, pur se in un vortice spesso ideologico affatto discutibile, questioni di primaria importanza, sulle quali non di rado si sorvola, circa la collocazione dei saperi nell’organizzazione economico-sociale del sistema, la presunta neutralità della scienza, il carattere classista dei processi formativi nel loro complesso, le ingessature autoritarie delle istituzioni e delle forme di partecipazione democratica non più sostenibili. La questione è che, soprattutto dagli anni Ottanta, almeno in Italia, quel paradigma è stato soppiantato da un altro – già anticipato dal 1973 in Inghilterra da Margaret Thatcher, allora Ministro dell’Istruzione – che ha eliminato quel che di positivo il precedente includeva: la ricerca della profondità storica dei fenomeni, oggi soppiantata vieppiù dal culto della superficie; una visione dei saperi che riusciva ad arginare una loro concezione puramente o prevalentemente strumentale; la centralità dei contenuti della formazione; il nesso inscindibile fra ricerca e didattica. Ritengo che nel quadro dei mutamenti intervenuti in ambito epistemologico, teorico e metodologico nel sistema dei saperi e nella visione della dinamica dei sistemi culturali, quel ‘positivo’ può e deve essere recuperato.
Un’altra considerazione complessiva riguarda la forma linguistica e l’atteggiamento verso la contemporaneità, che sembrano strettamente correlate. La lingua di questi primi numeri del «Siculorum» lascia nel lettore l’impressione di una diffusa aura di ‘cristallinità’ crociana: una prosa limpida, rigorosa, un argomentare mai faticoso, mai concentrico, sempre retto da una sorta di filo rosso tenuto in mano dal saggista, che mostra implicitamente ad ogni mossa di essere in grado di risolvere compiutamente i problemi che affronta. È come se si sentisse il distillato di un atteggiamento mentale preciso, il cui corrispettivo è non a caso la scelta di scrittori come Giusti, ovvero l’incomprensione per le manifestazioni del contemporaneo, resa manifesta dal saggio di Bottari su Primitivismo e civiltà. Questa lingua, questo stile di ragionamento, questo tipo di obiezioni al contemporaneo possono essere riletti oggi con maggiore equanimità, in un tempo come il nostro, culturalmente sopraffatto quasi dalla complicazione, dalla provvisorietà, dalla sfiducia nelle idee chiare e distinte?
Benigno – Certo, vi erano in quell’università, taluni aspetti che paiono meritevoli di essere recuperati. Uno di questi, relativo al mondo degli studi storici, era la dimensione problematica che l’idealismo storicista consegnava alla ricerca. Ad uno studente che fosse impegnato in una tesi veniva frequentemente posta la domanda fatidica: «Qual è il tuo problema?». Questa domanda valeva a sollecitare una consapevolezza maggiore delle ragioni attuali connesse all’affrontare un certo argomento, di quell’elemento che volta a volta fa della storia – crocianamente – una «storia contemporanea». Nel corso degli anni Sessanta, con la prevalenza della storia economico-sociale, questa consapevolezza si è andata perdendo e solo recentemente si tende a recuperarla. Certo, oggi porre quella domanda è forse più difficile e scomodo rispetto a settant’anni fa. Nel tempo del moderno vi erano dei grandi schemi ideologici che ordinavano la visione condivisa della realtà, e il mondo sociale li aveva talmente interiorizzati che si creava un corto circuito tra ciò che potremmo chiamare l’ordine delle cose e ciò che potremmo chiamare l’ordine dei pensieri. In questo processo di naturalizzazione il carattere problematico della ricerca era intellettualmente denso ma al contempo chiuso, come una navigazione che si svolge in un lago dalle sponde certe. Oggi la stessa invocazione di una maggiore consapevolezza teorica e metodologica si svolge invece come una navigazione in mare aperto, senza confini chiari e senza schemi ideologici condivisi di riferimento. E questo fa della ricerca storica, a ben vedere, un esercizio assai più interessante.
Massimilla – A mio parere la giusta accentuazione del carattere fluido e complesso della realtà in genere, e della realtà umana nello specifico, la quale non si accomoda con spontanea cortesia sul letto di Procuste delle nostre elaborazioni concettuali, non implica in alcun modo una deroga allo sforzo costante di conferire la maggiore determinatezza possibile ai concetti con i quali lavorano le scienze dell’uomo. Su questo punto (come su molti altri) resta per me di grande attualità la lezione dei ‘tipi ideali’ weberiani, che si configurano come strumenti euristici plastici e straordinariamente efficaci non già nonostante, ma il più delle volte proprio a causa del loro carattere ‘irreale’. Insomma, per dirla con una battuta, non si tratta di rinunciare alle «idee chiare e distinte», ma solo al pregiudizio – talvolta palese, più spesso ben mascherato – che le identifica con entità metafisiche delle quali i processi reali costituirebbero (in ogni senso possibile) la ‘realizzazione’.
Pinto – Terrei ben distinte le riflessioni sulla chiarezza della lingua di questi primi saggi e le posizioni, in specie di Bottari, sulla vicenda artistica contemporanea. Senza entrare più di tanto nel merito di un problema complesso, che proprio negli anni del secondo dopoguerra vide rigidamente schierati su fronti opposti le menti migliori del dibattito culturale, mi sembra evidente che la condanna, da parte di Bottari, di Massimo Campigli e Henry Moore, così come di Picasso e Paul Klee, si accompagna al deferente omaggio a Cézanne, agli espliciti riconoscimenti a Carlo Carrà, a Giorgio Morandi, a Scipione. In sostanza, la posizione di Bottari è di condanna del primitivismo, non della ricerca artistica contemporanea. Non è difficile, inoltre, scorgere in filigrana la polemica verso Lionello Venturi e non tanto ancora contro l’ingombrante Il gusto dei primitivi (Bologna 1926), nel quale il critico modenese aveva introdotto fra l’altro la sdrucciolevole nozione di «gusto», quanto piuttosto per l’evocazione nel testo di Bottari, e in chiave tutta negativa, dei nomi di George Roualt e Marc Chagall, per i quali proprio nel 1948 Venturi si faceva promotore di mostre personali nell’ambito della Biennale d’arte di Venezia, la prima dopo la pausa forzata del secondo conflitto mondiale.
E tuttavia, se è vero che «pochi altri studiosi italiani hanno nutrito per il Croce tanta deferenza, ammirazione ed amicizia quanta ne nutrì, costantemente, Lionello Venturi […]. È al Venturi, in grandissima parte, che si deve se in Italia si è formata una scuola di storia dell’arte d’impostazione crociana» (G. C. Argan, Lionello Venturi, in Letteratura italiana. I critici. Storia monografica della filologia e della critica moderna in Italia, vol. V, Milano, Marzorati, 1970, pp. 3357-3372, citazione a p. 3358), è altrettanto vero che pochi storici dell’arte in quegli anni non potevano non dirsi crociani. Sia pur con gradi diversi di eresia, a Croce e alle sue posizioni si rifacevano Venturi, Bottari e Ragghianti; la stessa apostasia di Roberto Longhi non aveva ancora consumato tutta la distanza dello storico dell’arte dalla proposta crociana: il primo numero di «Paragone» sarebbe apparso solo nel 1950. Da qui, credo, una comunanza di approccio alla scrittura che, senza derogare dalla profondità della riflessione, dalla validità della proposta, dalla ampiezza erudita dei riferimenti, si mostra insofferente verso lo scrupolo della citazione, l’inciampo della precisazione, l’asmaticità della annotazione; una scrittura che, sull’esempio di Croce, riesce a fare giustizia di quelle ormai decrepite formule retoriche, di quelle pretese moralistiche o pedagogiche «e cioè il punctum dolens della critica ufficiosa negli ultimi cinquant’anni», quella nelle cose d’arte «dei Molmenti, Ricci, Oietti» (R. Longhi, Viatico per cinque secoli di pittura veneziana, Firenze, Sansoni, 1946, ora in R. Longhi, Edizione delle opere complete. 10. Ricerche sulla pittura veneta: 1946-1969, Firenze, Sansoni, 1978, pp. 1-63, citazione a p. 39). Una scrittura alla quale, mi sembra, si stia quasi ineluttabilmente tornando, giusta l’ipertrofia, e spesso l’autoreferenzialità, di gran parte della pubblicistica scientifica che impone sempre più una chiara selezione dei punti di riferimento, una essenzialità ragionata delle bibliografie, un sempre più ineludibile affrancamento dalle onfaliche erudizioni fini a se stesse.
Pioletti – Parlavo prima del recupero del ‘positivo’ che c’era nel modello umanistico di università. Direi che questo recupero debba e possa avvenire anche nello stile di rappresentazione dei risultati della ricerca, che non è livello astrattamente formale, ma terminale di un approccio scientifico che sia fondato su un’acribia puntuale – che è dato riscontrare in diversi contributi dei primi fascicoli del «Siculorum» –, sulla messa in campo dei procedimenti funzionali alla dimostrazione di una tesi, all’esposizione dei dati su cui poggia, al fatto che siano verificabili. Non si tratta tanto di scelte strettamente linguistiche – la lingua non è statica –, quanto della qualità del nesso tra il cosa dire e il dire stesso. Esigenza, invero, che non è isolabile, anzi deriva da e porta a una messa in chiaro della funzione sociale della ricerca, della didattica, della cultura. Una funzione che non sia strumentale e confinata al ruolo di ambito delle risposte legate alle leggi del mercato, ma che sia presupposto critico per saper leggere il contesto storico nel quale si è inseriti, al fine di attivare in esso una presenza consapevole, riflessiva, capace d’interventi individuali e collettivi nella pratica della cittadinanza.
Lungo i due numeri della rivista si legge in controluce e si sente epidermicamente la presenza di un lievito morale e sociale dell’indagine storica e della ricerca nell’ambito dei saperi sull’uomo. Basti pensare intanto alla fiducia ‘illuministica’ che attraversa i saggi di Romeo sul Risorgimento in Sicilia, tema poi del suo primo libro importante e motivo della sua ‘proiezione’ romana. Ma non è secondario il fatto che questi numeri del 1948 dedichino uno spazio notevole alla poesia popolare, soprattutto grazie agli scritti di Carmelo Musumarra. Sono passati pochi decenni, eppure siamo lontanissimi da tutto questo. L’idea stessa di un sentire morale come anima della ricerca sembra non appartenerci più, così come il senso di una cultura intesa quale costruzione collettiva e inclusione dei soggetti linguisticamente e culturalmente ‘altri’. Seppur in forme nuove e all’altezza dei tempi, non vi sembra che si tratti di elementi oggi necessari per una rivitalizzazione degli studi umanistici? Non hanno bisogno forse oggi i nostri studi, per non cadere nell’insignificanza, di una rinnovata tensione morale e di una capacità di leggere e di aprire orizzonti di comprensione per testi, scritture, modalità linguistiche e tecnologiche diverse, pensiamo solo al variegato mondo della cultura giovanile?
Benigno – Quanto detto sopra vale ancor più se dalla dimensione problematica passiamo poi alla dimensione che, con una parola appartenente al lessico odierno (e non a quello del 1948), chiameremmo identitaria. A quel tempo le grandi macro-categorie ascrittive (la nazione, la classe, la fede) non erano ancora state messe in discussione e i costrutti culturali godevano di quella che Zygmunt Bauman ha definito una marcata «solidità», contrapponendola in modo discutibile alla presunta «liquidità» del nostro tempo. Le ricerche e gli studi pubblicati nel fascicolo di «Siculorum Gymnasium» parlano di questo. Le ricerche sulla poesia popolare, per dire, vanno considerate a ben vedere come un’indagine sull’anima della nazione; e il Risorgimento in Sicilia è la storia del suo inveramento nel caso italiano. Di fronte ai primi assaggi di un libro magistrale come sarà poi quello di Rosario Romeo, oggi noi possiamo solo provare due sentimenti contrastanti. Il primo è, certo, di ammirazione per un’opera scritta con una maturità inarrivabile da un giovane studioso (Romeo aveva 28 anni!), l’altro di perplessità. Perché bisogna riconoscere che dopo settant’anni occorre guardare a quella prima straordinaria prova di colui che forse è stato il più grande storico italiano della seconda metà del Novecento (Giarrizzo, a cui va il mio commosso ricordo, lo indicava come tale) come ad una sorta di monumento, che è necessario rimuovere per evitare che diventi un macigno, ostruendo l’interpretazione di quel periodo. Vi è infatti nel testo di Romeo la tendenza, peraltro del tutto normale a quel tempo, a mettere in linea il moderno e per così dire il «bene» e a contrapporgli l’arretrato e dunque il «male». Sicché il processo risorgimentale contrapporrebbe una Sicilia moderna e aperta al futuro ad una arretrata e «feudale». Ecco, noi oggi non siamo più tanto sicuri di contrapposizioni così nette. L’abbandono di tante sicurezze però non ci esime dagli obblighi civili connaturati alla ricerca umanistica, anzi li rafforza e ce ne impone di nuovi. Quelli che vengono da un mondo, l’odierno, più «oscuro» di quello di settant’anni fa, ma proprio per questo – anche – desideroso di parole di verità sottratte al caleidoscopio della politica delle identità.
Massimilla – Sono convinto che «un sentire morale», inteso nell’accezione più ampia possibile del termine, sia indispensabile agli ‘studi umanistici’ e alla loro «rivitalizzazione» per motivi d’ordine epistemologico. Cerco di spiegarmi in pochissime battute. Giusta la grande lezione kantiana, per un intellectus ectypus, per una ragione finita e discorsiva come quella dell’uomo, conoscere la realtà empirica non può voler dire rispecchiarla, ma solo rielaborarla e schematizzarla alla luce di un criterio di selezione. Ora, se ci interroghiamo sul criterio di selezione proprio degli studi dell’uomo sull’uomo (criterio di selezione che è connesso a filo doppio col loro oggetto specifico), ci accorgiamo subito che esso non è costituito dal ‘generale’ inteso come ciò che è ‘comune’ a una pluralità di casi presi in esame, come ciò che, nel fluire della realtà, si ripete identico nello spazio e nel tempo. Il criterio di selezione degli studi umanistici è piuttosto costituito dal ‘generale’ inteso come ciò che, si ripeta o meno nello spazio e nel tempo, è in ogni caso ‘significativo’ per tutti, giacché riveste (immediatamente o mediatamente) un’importanza e un valore per lo studioso e per coloro cui lo studioso si rivolge. Da ciò discende che la pur necessaria ‘avalutatività’ degli studi umanistici si radica in maniera inestirpabile nel ganz Mensch, nell’uomo tutto intero che valuta e vuole, e che, mediante il suo valutare e il suo volere, possiede la capacità di conferire un senso alla infinità priva di senso che lo circonda e lo attraversa, laddove il senso in questione (quale che sia) può essere secondo lui condiviso o anche oppugnato, ma almeno compreso da altri uomini. Se per «sentire morale» s’intende quest’attività di valorazione intrinsecamente relazionale che è propria dell’uomo, allora il sentire morale non può mai essere artificialmente disgiunto dagli studi umanistici e dai loro alterni destini.
Pinto – Sarà che dal punto di vista dello storico dell’arte l’attacco alla conservazione del patrimonio artistico e naturale è sempre più virulento e sistematico, che la struttura stessa degli organi di tutela è in via di modernizzante disarticolazione, che in maniera direttamente proporzionale alla popolarità di certe rassegne espositive cresce l’inconsapevolezza delle ragioni dell’arte, ma almeno nelle parti più avvertite della ricerca scientifica italiana l’esigenza di legarsi all’impegno civico, morale, politico è ampiamente sentita. Le parole di Longhi – «la storia dell’arte che ogni italiano dovrebbe imparar da bambino come una lingua viva (se vuole avere coscienza intera della propria nazione): serva, invece, e cenerentola, dalle classi medie all’università; dalle stesse persone colte considerata come un bell’ornamento, un sovrappiù, un finaletto, un colophon, un cul-de-lampe di una informazione elegante» (R. Longhi, Lettera a Giuliano, «Cosmopolita», 30 dicembre 1944, ora in R. Longhi, Edizione delle opere complete, 13: Critica d’arte e buongoverno: 1938-1969, Firenze, Sansoni, 1985, pp. 129-132) – sono state giustamente più volte recentemente ricordate. Ma vorrei sottolineare come ogni atto della ricerca storico artistica – sia esso innesco di accostamenti, proposte, epifanie, o sia più ambizioso tentativo di sistemazione e interpretazione del noto – non possa che risultare sempre concreta proposta di civile resistenza. Che abbia come oggetto della sua attenzione celebrate presunte eccellenze o popolari espressioni delle «fatiche di chi opera», per usare le parole di Pontormo, lo storico dell’arte sa bene che le une sono inscindibili dalle altre e che insieme costituiscono il panorama di pietra, legno, tela, marmo e quant’altro delle città e dei borghi che abitiamo, delle case e degli uffici che quotidianamente ci accolgono, delle strade che percorriamo; la cui sopravvivenza, va da sé, è intimamente connessa alla nostra stessa, alla capacità di comprendere come tutte esse, ma a ben vedere noi stessi, siano il sedime composito e inseparabile nel quale affondano le basi di qualsivoglia nuova espressione, apparente alterità. E del resto se, pensando certo ai manufatti, con il Longhi del 1950 siamo ancora impegnati a «toglierli dal mutismo adespoto così pericoloso per la stessa loro incolumità fisica di oggetti; “parlarli”, bisogna», con Albert Camus sappiamo che «ogni generazione, senza dubbio, si crede destinata a rifare il mondo», la nostra «sa che non lo rifarà»; il nostro «compito è forse più grande: consiste nell’impedire che il mondo si distrugga». E tuttavia, per quanto vana fatica questa possa apparire, sempre con Camus possiamo credere che «tutta la silenziosa gioia di Sisifo sta in questo. Il destino gli appartiene, il macigno è cosa sua […]. Bisogna immaginare Sisifo felice».
Pioletti – Dal mio punto di vista la domanda è: si profila nell’oggi una nuova prospettiva che dia senso nuovo agli studi umanistici? Una ragione nuova per una tensione morale che conferisca statuto rinnovato al lavorìo scientifico e didattico che ci compete? Direi di sì, un sì non volontaristico, ma che deriva da una riflessione sull’incessante dinamismo che connota il campo delle scienze, tutte, nonché sulle grandi questioni che oggi attraversano il vivere civile nel contesto di quella che comunemente si definisce globalizzazione. Abbiamo insistito in altra sede (si veda la mia relazione su Quali saperi umanistici oggi, in occasione del Secondo Colloquio del DISUM del 26-27 ottobre 2015) sul dialogo che non da oggi intercorre fra scienze fisico-naturali e scienze umanistiche, e, più che dialogo, sull’interazione instauratasi fra campi scientifici diversi, ma non opposti, come in tempi non remoti si intendeva: l’informatica umanistica, le scienze cognitive applicate alla filologia, alla linguistica, alla critica letteraria, le esperienze di ‘medicina narrativa’, ‘legge e narrativa’, ‘matematica e narrativa’, la sociobiologia, tempo e spazio nel testo dopo la teoria della relatività di Einstein e la fisica quantistica, solo per fare qualche esempio. E abbiamo insistito sull’affermarsi anche in Italia, invero con un certo ritardo, di filoni di ricerca quali i gender studies, gli studi post-coloniali, quelli di geografia umana e di una rinnovata antropologia culturale, quelli sul rapporto con natura, ambiente, paesaggio, clima. Il tema dell’alterità ne è al centro, in tutte le sue angolature: uomo-donna, le culture altre, i popoli altri, le religioni altre, i fenomeni di diseguaglianze crescenti che hanno invaso nuovi gruppi sociali, nuove generazioni, le nuove migrazioni, la fuga dalle guerre. Siamo nel vivo, e al centro, dei conflitti che oggi ci attraversano non solo come sistemi sociali, ma come persone.
Buona parte del secondo numero del 1948 è occupato da un lungo saggio di Bruno Panvini su Giraldo de Bornelh. Si tratta di pagine dedicate ad un’interpretazione serrata, dove lo studioso cerca di ricostruire e di mettere in stretto rapporto i testi del grande poeta e la sua travagliata esistenza. È un modo, molto riconoscibile, di professare e praticare un atteggiamento filologico, ma anche la manifestazione di un senso degli studi romanzi, che attraverso i loro maggiori esponenti, negli stessi anni, contribuivano a ricostruire un mondo lacerato dalla guerra e diviso da odi e inimicizie mortali. Come a dire: la filologia e gli studi come alternativa alla guerra, come ponte gettato tra i popoli e le culture. È possibile oggi ripensare la filologia, in senso lato e in tutte le sue declinazioni, quale sapere e atteggiamento capace di ascolto delle diversità, di contaminazione culturale, di creazione di ponti e di orizzonti condivisi? E se sì, secondo voi, come dovrebbe essere?
Benigno – In questo senso il recupero della grande tradizione filologica è cruciale. Non perché oggi il problema della verità si possa risolvere con la vecchia e rinsecchita formula della differenza tra fonti primarie e fonti secondarie, ma perché esso risulta cruciale. Oggi che siamo consapevoli del carattere opaco, sempre interpretativo e perciò non trasparente delle fonti, la tradizione filologica serve allo storico come insostituibile risorsa per poter credibilmente stringere col lettore il suo necessario patto di verità. Il lettore non chiede infatti agli studiosi di storia (in senso lato: storici della letteratura, storici dell’arte, storici dell’economia, storici del costume, storici delle istituzioni etc.) di trasformarsi in narratori, e di esercitarsi perciò nell’ambiguo esercizio della fiction, ma di spiegargli, possibilmente con parole scevre da astrusi linguaggi disciplinari, come sono andate davvero le cose. Di fronte a questa sfida spesso gli storici (ma lo stesso avviene in altri settori delle scienze umanistiche) talora si ritraggono, accusando chi cerca di mantenere un legame tra ricerca scientifica in campo storico-sociale e opinione pubblica di far prevalere una dimensione eminentemente ‘divulgativa’, che offuscherebbe la nitidezza della pura ricerca accademica. Pur consapevoli dei rischi che comporta lo ‘sporcarsi le mani’, è dubbio che ritrarsi da tutto questo, rinserrandosi nella torre eburnea del sapere, salvi: mentre è certo che fa correre ai nostri studi il rischio mortale della insignificanza sociale.
Massimilla – La questione posta mi fa venire in mente il modo in cui il grande romanista alsaziano Ernst Robert Curtius concepiva, negli anni difficilissimi della Grande Guerra e del primo dopoguerra, i pioneristici studi di letteratura francese contemporanea che andava conducendo. Come si legge in una lettera a Heinrich Mann del novembre 1917, farsi mediatore dello ‘spirito francese’ presso i ‘giovani tedeschi’ significava per lui lavorare al «grande e serio compito dell’avvenire», vale a dire alla costruzione dell’asse portante di un’Europa intimamente pacificata. Ma Curtius concepiva il proprio lavoro filologico come una risposta all’appello delle «potenze dell’origine», identificate con quella «unione del cristianesimo con la romanità» nella quale, fin dagli anni giovanili, egli riconosceva «la sostanza stessa dell’Europa». Ecco, c’è da chiedersi se la messa in crisi, secondo me irreversibile, di presupposti ‘essenzialistici’ di questo tipo consenta ancora di «ripensare la filologia, in senso lato e in tutte le sue declinazioni, quale sapere e atteggiamento capace di ascolto delle diversità, di contaminazione culturale, di creazione di ponti e di orizzonti condivisi». A me non sembra che un esito di questo genere sia necessariamente garantito, ma nemmeno escluso a priori dal sapere filologico, inteso – per dirla ancora con Fulvio Tessitore – come «lo studio straordinario e terribile della “nuova scienza” e della “nuova storia”».
Pinto – Non troppi anni fa una studiosa, allieva diretta di Longhi, rivendicava con orgoglio di essere riuscita a scrivere un intero libro senza mai usare il così comodo, e a volte apparentemente insostituibile ma altrettanto ormai carico di disvalori, lemma ‘padania’. Il ricordo vale, al di là dell’aneddoto, perché subito addita una delle apparenti colpe maggiori della filologia storico artistica: la sempre più sottile distinzione in scuole nazionali, regionali, cittadine, non esente spesso, va da sé, di connotazioni campanilistiche e immediatamente strumentalizzabile da interessate quanto superficiali ricostruzioni identitarie. Uno stigma connaturato alla stessa nascita della disciplina, alle Vite di Giorgio Vasari, il cui toscanocentrismo è ampiamente riconosciuto dagli studi. E tuttavia proprio la migliore storia dell’arte del Novecento ha indicato in modo sempre più netto come l’acribia filologica schiudesse diverse prospettive, come la fenomenologia artistica andasse interpretata come storia delle contaminazioni, degli incontri, dei meticciamenti fra culture diverse e lontane. Una storia dell’arte fatta di cosmopolite officine ferraresi e di promiscue convivenze nella Roma di primo Seicento, e poi con Ferdinando Bologna di «rotte mediterranee della pittura» e di dirette «esperienze delle “cose naturali”», ma che già in pieno regime fascista poteva coraggiosamente fornire «un valido rinforzo alla critica dei torbidi concetti nazionalistico-estetici, distruttori di ogni verace comprensione e giudizio dell’arte: i quali negli ultimi tempi, incoraggiati da eventi e situazioni politiche, si sono fatti irruenti e prepotenti, quasi si potrebbe dire in ragione della stessa loro inconsistenza logica» (B. Croce, Recensione a R. Longhi, Arte italiana ed arte tedesca, Firenze, Sansoni, 1941, «La Critica», 40, 1942, pp. 161-162, citazione a p. 161). Del resto, è proprio dagli studi più correttamente indirizzati che viene indicato come i concetti, e in certi casi le forme, possano anche essere trasmessi attraverso relazioni, copie e traduzioni ma che le tecniche, il modus operandi, lo specifico di ciò che poi chiamiamo le opere d’arte lo si comprende solo dal contatto ravvicinato, dall’ispezione diretta, dal corpo a corpo.
Pioletti – Il 1948 è l’anno di pubblicazione della prima edizione di Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter di Ernst Robert Curtius: la Tradizione, vista nella ricerca e nella ricostruzione della topica e dell’articolazione storico-strutturale delle sue forme, sarebbe «forma mentale e strumento fondante del ruolo sociale e del potere dei colti» (R. Antonelli, Filologia e modernità, in E.R. Curtius, Letteratura europea e Medio Evo latino, Firenze, La Nuova Italia, 1992 («Classici 1»), p. XXXII). Ma del 1946 è Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur di Erich Auerbach, che si muove nell’alveo di esigenze comuni, ma con una visione e metodi di ricerca diversi (di una stilistica che dal frammento risale alla totalità, come in Spitzer, e nella quale è «l’attenzione tecnico-retorica alle strutture linguistiche, non più esclusiva e nemmeno dominante; la trascende un costante riferimento alle strutture immanenti dell’esperienza reale» (A. Roncaglia, Saggio introduttivo a E. Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, Torino, Einaudi, 2000, p. XXX). E al 1947 risale Fra Oriente e Occidente. Ricerche di storia greca arcaica di Santo Mazzarino che dal magistero di Luigi Pareti ebbe a trarre fondanti categorie critiche nello studio della grecità periferica e delle reti interorientali che la caratterizzarono, in una linea interpretativa ‘anticlassica’ (G. Giarrizzo, Santo Mazzarino: un maestro, in Id., Per una storia della storiografia europea, vol. 1, Acireale, Bonanno, 1995, pp. 191-250). Ma in questo selettivo richiamo a studi che vedono la luce nei primi anni del secondo dopoguerra è da inserire, per i risvolti che ha presentato e presenta anche nell’oggi, la pubblicazione nel 1949 de Il “Libro della Scala” e la questione delle fonti arabo-spagnole della “Divina Commedia” di Enrico Cerulli e de La escala de Mahoma di Jose Muñoz Sendino: il ritrovamento dell’anello mancante alle ipotesi di Miguel Asín Palacios esposte in Escatología musulmana en la Divina Commedia (1919), cioè delle versioni latina e antico-francese del Libro della Scala, tuttora ‘pietra d’inciampo’ della dantistica, e non solo.
Era un modo per operare dal punto di vista della filologia in vista di una creazione di nessi, di reti, di dialoghi, capaci di creare ponti dentro l’Europa e tra Oriente e Occidente. Oggi è tempo di nuove guerre, di stragi terroristiche che vengono da gruppi sedicenti islamici e che richiedono, anch’esse, un documentato ripensamento sulle loro cause non certo per giustificarle, ma, al contrario, per respingerle fuori dalla storia. A noi compete un decisivo ruolo di diffusione della conoscenza di realtà che non sono lontane, ma fra noi, di semina della cultura del dialogo, di potenziamento di relazioni scientifiche e formative paritarie in prospettiva euromediterranea. Quanto sterile un pensiero che non trovi in quello umanistico un connettore, la trama che riconduca alla comprensione di ciò che ci circonda, l’orizzonte per costruire, non domani ma oggi, un futuro di giustizia sociale e di pace!
E se alla filologia volgiamo ancora lo sguardo, alla ricerca della storicità e del dato testuale che segna, ad esempio, l’intervento di Bruno Panvini su Giraldo di Bornelh (II fascicolo 1948 del «Siculorum), »non possiamo non ricavarne, all’un tempo, una lezione e l’occasione per una rivisitazione della funzione della filologia stessa. Approccio trasversale a una molteplicità di campi disciplinari e necessario habitus mentale portante per saper leggere il mondo, ancor più oggi, di fronte al diluvio dell’informazione, alla manipolazione che subisce, alla superficialità delle sue immagini, alla povertà dei suoi contenuti. Metodi e campi di studio della filologia – e a quella romanza pour cause mi riferisco – si sono arricchiti: dalla filologia materiale all’affinamento della critica testuale anche tramite l’utilizzazione degli strumenti informatici; dallo studio dei nessi intertestuali a quello delle relazioni interareali fuori da una visione rigidamente eurocentrica; dall’attenzione al mondo del folclore all’elaborazione di una più compiuta antropologia del testo. Una filologia che vive il suo insito problematismo, come rilevò Contini, nel rapporto fra passato e presente e che si pone la finalità di rendere, nell’ora della leggibilità, i testi parola vivente. E questo, ritengo, sia compito non solo dei filologi.
Tags
SAPERI UMANISTICI , UNIVERSITÃ DI CATANIA , FACOLTÃ DI LETTERE E FILOSOFIA , SCIENZE UMANE , CONOSCENZA
Categoria
Nessuna
Scarica il PDF